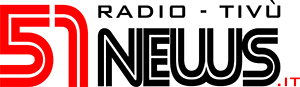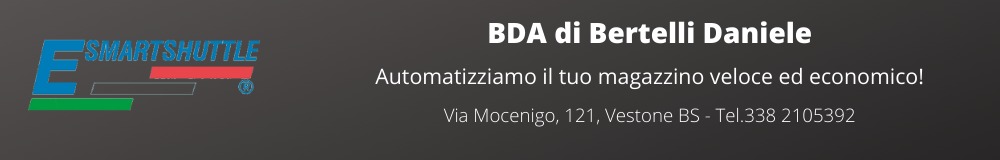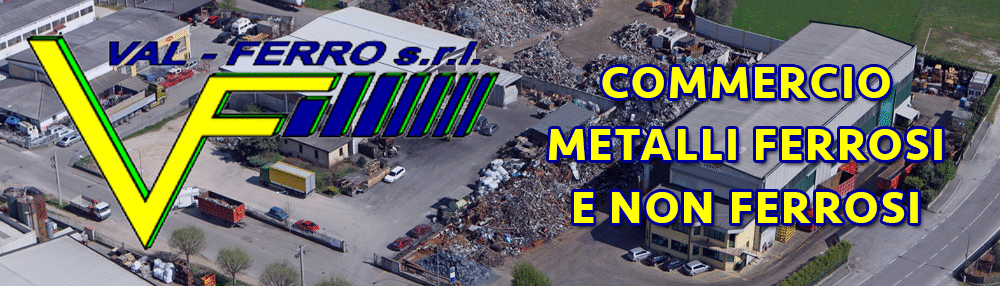Film pollice giù, attori pollice su. Le ultime cartucce sparate dal concorso del settantesimo Festival di Cannes sono curiosamente accomunate da due fattori: sono tutti film discreti/mediocri, ma al contempo sono capaci di offrire prestazioni attoriali davvero memorabili.
“Good Time” dei giovani fratelli americani Ben e Josh Safdie è un action movie che vede Robert Pattinson tra rapine e fughe, tra luci al neon e musica elettronica, facendo sì che le atmosfere e le scenografie di una New York crepuscolare, il tutto vestito da un manto di suono pregevole, siano le reali protagoniste del film. Connie, il personaggio interpretato da Pattinson, che tra le altre cose cerca anche di far evadere il fratello/complice (per altro handicappato mentale) dopo che questi è stato catturato, deve scappare compiendo una interminabile quanto improbabile fuga dalla polizia e probabilmente da sé stesso; l'impeccabile lavoro di pedinamento che i registi compiono sul personaggio non riesce però a restituirne l'idiosincrasia che questi nutre nei confronti del mondo intero (fratello a parte), mettendo in atto una fuga che è metafora di un lavoro che tenta di evadere dal genere dentro cui si sviluppa, ma che fa emergere tutti i propri limiti, pur restando un tentativo molto accattivante di creare atmosfere suggestive e avendo il merito di dare a Pattinson la possibilità di fare la migliore interpretazione della propria carriera.
Sul versante Turco-alemanno non v'è dubbio che Fatih Akin, in concorso con “In the fade”, dimostri di saper maneggiare il dispositivo cinematografico in maniera impeccabile, costruendo l’intero film attorno alla figura di Diane Kruger. Ciò che sembra mancare al film, però, è proprio la sostanza. In definitiva si tratta della storia di una donna che perde il marito e il figlio in un attentato terroristico di stampo razzista. Vengono tirati in ballo molti argomenti, dall'efficacia della detenzione come strumento di reinserimento nella società fino al "problema" delle organizzazioni (chiamiamoli partiti...) neonaziste contemporanee, passando per droga, tentativi di suicidio, drammi famigliari, e quant'altro.
Che la carne al fuoco sia troppa è evidente dato che Akin proprio non riesce a grattare via la superficie, lasciando allo spettatore una trama abbozzata e ricca di estetismi che in alcuni casi possono risultare anche abbastanza fuori luogo, soprattutto nella seconda parte. “In the fade” procede per capitoli, in realtà tre macro-capitoli, ed è un revenge-film che inizia in maniera onestamente accattivante e interessante, ma che pian piano si perde verso un finale in parte telefonato e in parte confuso.
Con una trama plausibile quanto un elefante che cucina una Carbonara, la regista britannica Lynne Ramsay mette subito in chiaro i suoi intenti. Nella velocissima ora e mezza di "You were never really here" compie un lavoro di destrutturazione del genere, portando il proprio personaggio (un Joaquin Phoenix che fa la parte del giustiziere privato, veterano ‘inciccionito’ e pieno di cicatrici) all'interno di una spirale di violenza che di fatto è essa stessa la scelta narrativa e stilistica del film.
Incaricato di ritrovare la figlia di un senatore, rapita da alcuni pedofili, il personaggio di Phoenix compie la propria ricerca senza ostacoli, trovando e annientando chiunque con una facilità disarmante. In un procedere molto lineare di una trama di per sé scarnificata, ecco quindi affacciarsi alcuni flashback che ci danno solo qualche indizio sull'infanzia del personaggio e sul valore etico che assume la sua "missione": perché di fatto si tratta di un cammino verso la redenzione, un colpo di spugna salvifico nei confronti di un passato tremendo, come se "non fosse mai realmente stato lì". Un lavoro interessante, quello della Ramsay è un film che (pur non spiccando davvero mai il volo) fa il proprio dovere appieno, che si assume un compito e lo porta a termine e che sa anche ipnotizzare e divertire a dispetto dell'apparente banalità dell'azione.
Deludente invece il film di chiusura del Festival, “D’après une histoire vraie” di Roman Polanski, presentato fuori competizione.
Mettendo in scena la vicenda di una scrittrice che fa amicizia con una ammiratrice, già dopo dieci minuti è chiaro che i topic del film saranno ambiguità, stalking, tematica del doppio e legame artista-musa.
Come un gioco di specchi, la protagonista è risucchiata in un vortice che dovrebbe suscitare tensione e inquietudine ma che purtroppo lascia spazio a fin troppi risolini in sala. Con una trama fin troppo lineare e che procede quasi per passaggi telefonati, il film si trascina stancamente verso un finale che non regala nulla di nuovo e che risulta, anzi, essere sorprendente (in negativo, ovviamente) a chi si aspettava la “forza” e la tensione che da sempre animano i film del grandissimo regista polacco.
Tra soleggiate (ma fresche) giornate di sole, enormi assembramenti e ingenti misure di sicurezza si chiude un Festival che ha riservato le sorprese migliori nelle sezioni distinte dalla Selection Officielle. Oltre ai film (italiani e no) di cui abbiamo già parlato in precedenza, basti pensare a “La novia del desierto” del duo argentino Atan/Pivato, o a “Directions” del bulgaro Komandarev passati ieri nella sezione Un certain regard, tra i lavori migliori visti quest’anno.
Premiati invece i film della sezione parallela Quinzaine des réalisateurs: vince “The rider” di Chloé Zhao, mentre l’italiano “A Ciambra” di Jonas Carpignano si aggiudica l’European Cinema Label che permetterà al giovane cineasta di usufruire dei finanziamenti e delle agevolazioni offerte dall’Europa Cinema Network, con la motivazione «Il film sottolinea il potenziale magico del cinema, trasportando il pubblico in un ambiente che si è visto raramente, ovvero quello di una comunità rom al sud d’Italia. Il dialetto usato nel film si era potuto sentire di rado sul grande schermo e rappresenta un vero e proprio personaggio»
Nicola Cargnoni