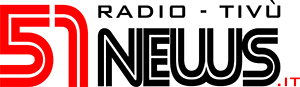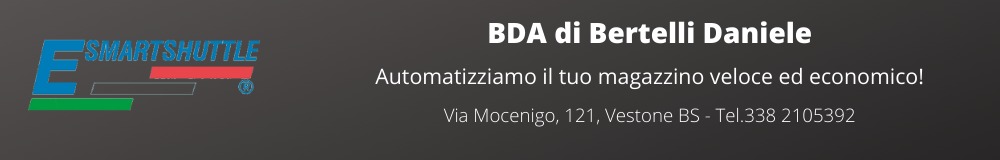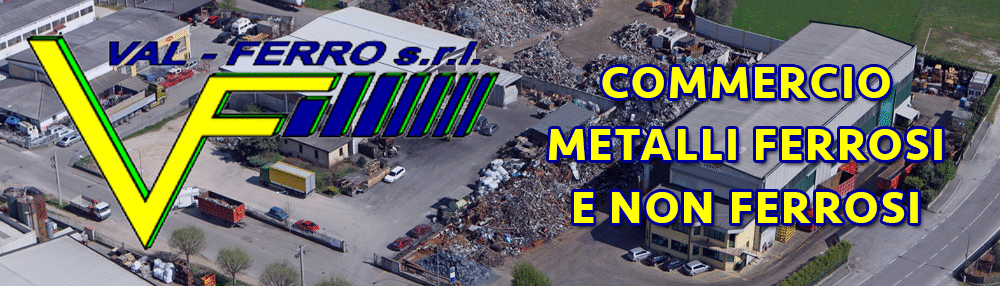Don Giuseppe Tedeschi (Iseo 1883-Brescia 1973) collaboratore e poi responsabile del settimanale cattolico bresciano “La Voce del Popolo”. Dopo l’inizio della prima guerra mondiale nel 1914, schierò il giornale su decise posizioni neutraliste.
Nell luglio del 1916 si arruolò come prete-soldato in Sanità. Nel settembre venne inviato sul fronte orientale, a Salonicco. Infine il 6 marzo 1917 fu nominato cappellano presso il 262° reggimento fanteria della brigata “Elba”.
Svolse il suo compito con grande impegno e una forza tale da renderlo una figura conosciuta e apprezzata dai soldati. Fin da subito si propose di esercitare il suo incarico con modalità alle quali non venne mai meno, scontrandosi con una concezione del ruolo di cappellano condivisa da molti ufficiali, ma non poteva essere da lui accettata in alcun modo, come scriveva il 17 aprile del 1917:
«Mi pare che ben pochi comprendano il compito del Cappellano qui: credono io debba eccitare i soldati ad una guerra spietata. Sento di non poterlo fare. […] sento ancora che il mio compito è quello di consolarli nelle loro sofferenze, di supplire al loro fianco la mancanza dei loro cari e dei loro sacerdoti».
Catturato dopo la battaglia di Caporetto, fu inviato in Germania, prima in un lager presso Rastatt e poi a Celle, nei pressi di Hannover.
Poco dopo la fine della guerra stende le sue memorie di prigionia, pubblicate in volume nel 1947. Esse hanno in primo luogo un’importanza storica perché in esse emerge una realtà, quella dei prigionieri della Grande Guerra, dimenticata anche dalla storiografia, almeno fino alle ricerche di Giovanna Procacci agli inizi degli anni Novanta. Ma assumono anche un’importanza morale. Finalmente i “vinti di Caporetto” o “gli imboscati d’Oltralpe” come furono definiti con disprezzo, trovano la voce. Don Peppino si fa portavoce delle vicende, dei pensieri, dei sentimenti di tutti i soldati, anche di coloro che non possiedono le parole per raccontarli.
Le sue memorie costituiscono una narrazione avvincente, in una lingua moderna e vivace, di molte storie di uomini, di sentimenti, di vicende e di riflessioni. Per don Peppino furono così fondamentali i lunghi mesi della prigionia che, ritornato a casa nel febbraio del 1919, scrisse: «sono contento: contento di aver partecipato alla guerra; contento di aver sofferto la prigionia. L’esperienza che ho fatto degli uomini e delle cose nessuno avrebbe potuto insegnarmela. Se mi domandassero qual è la parte migliore della mia vita, dovrei proprio rispondere senza esitazione: questa! Sono contento di aver scritto anche queste pagine perché se alcuno le leggerà, un giorno, gli ispireranno l’orrore all’ingiustizia e lo persuaderanno di uno dei tremendi mali che genera la guerra».
Che cosa racconta don Peppino?
Racconta un mondo in cui dominava per lungo tempo la fame, che determinava il comportamento dei prigionieri che, lentamente e inarrestabilmente, rischiarono di perdere oltre la loro vita anche la loro dignità, come raccontò in uno dei brani più intensi delle sue memorie.
Di notte, tormentato dalla fame, aprì l’uscio della baracca, e si buttò disperato a terra e inghiottì manciate di erba, quando alzò lo sguardo al cielo e allora, scrive, « Io non so cosa sia avvenuto in me d’improvviso; so che il contrasto, fra quel cielo che mi ricordava d’esser uomo e quell’erba che pareva sconfessare questa umanità, m’ha colpito stranamente: ho capito che con quel pugno di verde tra i denti ero diventato bestia e “ no, mi son detto, non voglio morire da bestia!” L’erba m’è colata dalla bocca e, spinto da una energia che non mi parve mia, sempre carponi, sono rientrato nella baracca»
Quando la fame non fu più un pensiero ossessivo e a Cellelager le condizioni di vita per quanto pesanti erano molto migliorate, perché cominciarono ad arrivare i pacchi di alimenti inviati dai familiari don Tedeschi, parlando con il cappellano tedesco del campo, si rese conto, per la prima volta, di una tragica realtà che gli era completamente sconosciuta che «i nostri soldati italiani nei campi di concentramento o sui lavori, nelle miniere, soffrono più assai di noi. Senza notizie da casa, senza assistenza, affamati, cenciosi, sembrano peggio che figli di nessuno. […] Farò la mia domanda al ministero della guerra germanico per restituirmi ai soldati».
La sua richiesta di poter dare assistenza religiosa ai soldati nei loro campi di concentramento non fu isolata. Insieme a lui presentò la stessa richiesta anche don Ulderico Masti, un giovane confratello fiorentino.
Nel lager di Hameln si trovarono di fronte a condizioni di vita e di lavoro dei soldati inaspettatamente dure. Qui vivevano con grande fatica e pena uomini affamati e disperati di tutte le nazioni e di tutte le lingue. Ai due sacerdoti, nell’impossibilità di fare altro, non restò che confortare i vivi e assistere i morenti negli ultimi istanti della loro vita.
L’alimentazione prevista per i soldati, che lavoravano nelle campagne, nelle fabbriche e nelle miniere, era così scarsa che il lavoro coatto divenne per loro un lento e doloroso cammino verso la morte per sfinimento o per le malattie causate dal freddo e dalla fame.
A partire dalla metà di settembre i due sacerdoti furono autorizzati anche a visitare e ad assistere i soldati nei luoghi di lavoro fuori dal lager. Da quel momento iniziò un’attività senza soste. Scrive: «Ho visto miserie, ho raccolto la storia di dolori disperati, ma ovunque sono stato ricevuto con tale desiderio e compensato con tanta confidenza da dover benedire Iddio d’aver permesso la mia sventura che mi conduceva a confortare quella di tanti miei fratelli».